Una famosa copertina di Joe Cocker lo ritrae nel gesto dell’ombrello: si tratta dell’immagine del disco Only mad dogs and englishmen del 1970. Il titolo dell’Lp si riferisce a sua volta ad una canzone di Noel Coward, cantata per la prima volta nel The Third Little Show al Music Box Theatre di New York il 1 giugno del 1931, ma viene da una espressione idiomatica, forse inventata da Kipling «only mad dogs and englishmen go out in the midday sun» che celebra la “pazzia” degli soldati inglesi nelle zone tropicali, capaci di camminare in pieno sole meridiano. Molti secoli prima in Oriente, e precisamente nella fiaba della Lampada di Aladino, curiosamente, ritroviamo un’entità che, sin dalle origini del mondo, fa riferimento allo strano detto di Kipling il quale, essendo notoriamente un Libero Muratore, come si capisce molto bene nella novella L’uomo che volle farsi Re, aveva il gusto esoterico di combinare racconto e simbologia tradizionale. E allora torniamo al nostro povero ragazzo per ricapitolarne la storia.
La lampada di Aladino
Questa fiaba dovrebbe far parte delle Mille e una notte anche se non era presente nella versione originale dell’opera: venne infatti aggiunta da Antoine Galland, per l’edizione francese dove occupa dalla 310ª alla 342ª notte. Un racconto molto lungo dunque, che Galland ha preso in prestito da testi di fiabe persiane. La storia si apre con il nostro Aladino, un ragazzo scansafatiche che vive in una città della Cina. Questo particolare è già molto curioso, dato che il resto del racconto, ed i nomi stessi dei personaggi, sono di chiara derivazione araba.
Un giorno Aladino riceve la visita di un necromante maghrebino, che convince la madre vedova ad affidargli il giovane per farne un suo assistente. Il mago porta Aladino fuori città; giunti in un dato luogo, esegue un oscuro rituale che apre l’accesso ad una caverna dove è nascosto un tesoro, del quale solo Aladino può impadronirsi. La caverna è piena di ricchezze, ma Aladino non potrà raccoglierle se non troverà una vecchia lampada a olio che il mago desidera; prima che Aladino entri, il mago gli consegna un anello fatato che servirà da talismano.
Il ragazzo si introduce nella caverna e trova la lampada; mentre torna indietro, il peso dei gioielli che ha intanto raccolto gli impedisce di salire gli ultimi gradini per tornare fuori. Chiede dunque aiuto al mago, che però vuole prima la lampada; sospettando che il mago voglia lasciarlo nella caverna una volta ottenuta, Aladino rifiuta di consegnargliela: il mago richiude la caverna e così il ragazzo rimane in trappola. Passati due giorni, Aladino strofina involontariamente l’anello magico: subito appare un jinn, che si dichiara suo servitore ed esaudirà qualunque suo desiderio: il ragazzo chiede allora di essere liberato. Tornato dalla madre Aladino le racconta tutto; rimasti senza cibo e denaro le propone di vendere la lampada: quando la donna tenta di lucidarla ne esce un altro jinn, più potente del primo, che si offre di servire i portatori della lampada. Aladino comanda alla creatura di portare del cibo, che il jinn fa apparire su piatti d’oro e d’argento. Da quel giorno, con l’aiuto del jinn madre e figlio riescono a vivere in prosperità; grazie ai proventi della vendita delle preziose stoviglie, Aladino riesce ad aprire un negozio di stoffe.
La storia ha il suo epilogo nel matrimonio tra Aladino e la principessa Badru l-budūr figlia del Sultano, dopo che il necromante cerca di sottrargli la lampada fatata con l’inganno. Ma, sempre con l’aiuto dei jinn, Aladino riuscirà a prevalere e due sposi vivranno infine felici e contenti.
Il jiin
Come si vede la figura centrale della fiaba è il jinn, una entità centrale nella cosmologia e nella tradizione religiosa del mondo arabo-islamico, con radici che precedono l’Islam e si estendono nella cultura preislamica. La sua presenza attraversa mitologia, religione, folklore e letteratura.
Prima dell’avvento dell’Islam, nel VII secolo, gli Arabi credevano nei jinn come spiriti invisibili della natura. Nella religione preislamica erano associati a luoghi remoti e selvaggi, come deserti e rovine; venivano considerati esseri soprannaturali, capaci di interagire con gli uomini, sia in bene che in male. Alcuni erano venerati, altri temuti: erano oggetto di culti locali e invocazioni magiche. I poeti preislamici (come i kāhin, indovini-sciamani) affermavano di ricevere da loro l’ispirazione poetica.
Con il Corano, la figura del jinn viene integrata e reinterpretata in chiave monoteistica. Il libro non ne nega l’esistenza, ma la ordina in una cosmologia unitaria creata da Allah. A questo proposito è interessante la loro genesi: sono creati da fuoco senza fumo (Corano 55:15) — diversamente dagli uomini (creati dalla terra) e dagli angeli (dalla luce). Sono esseri dotati di libero arbitrio, come gli esseri umani. Possono essere credenti o miscredenti (musulmani, politeisti, demoniaci, ecc.). Questo processo creativo ricorda , per analogia inversa, la creazione della stirpe umana nella cosmologia orfica, in cui la nostra specie sarebbe stata creata dal fumo della dissoluzione del corpo di Dioniso cotto dai Titani.
Il più famoso dei jinn è Iblis, che rifiutò di prostrarsi davanti ad Adamo. Anche se spesso identificato come uno shayṭān (diavolo), è chiamato jinn: «E quando dicemmo agli angeli: Prosternatevi davanti ad Adamo, si prosternarono, eccetto Iblis, che era uno dei dèmoni e che si rivoltò all’Ordine di Allah». (Corano 18:50). Nel pensiero popolare islamico e nel sufismo, la distinzione tra jinn e shayṭān è spesso sfumata: alcuni jinn malvagi diventano shayāṭīn (plurale di shayṭān), spiriti tentatori, o possono possedere gli esseri umani, causando malattie o comportamenti anomali (concetto presente anche nei testi giuridici e nelle pratiche esorcistiche islamiche).
Il Genius
Il corrispettivo del jinn, nell’antica religione romana è il genius, una figura altrettanto complessa e ambivalente, che rappresentava una sorta di spirito tutelare personale. È un’entità profondamente radicata nella religione domestica, nella politica e nel simbolismo imperiale di Roma. La parola deriva probabilmente dal verbo gignere (generare), con evidenti assonanze fonetiche con l’omologa parola araba. Il genius è quindi legato alla generazione, alla creazione e alla vitalità. Come nel mondo arabo musulmano, ogni persona, famiglia, luogo o collettività aveva un proprio genius che ne rappresentava la forza vitale o protettiva, il genius loci, ma anche una forza che contrastava in maniera malevola la buona sorte sia dei luoghi che delle persone. Ancora oggi, per dire che qualcuno a qualcosa non ci convince o non ci pace usiamo l’espressione «non mi va genio».
Questo perché, in particolare, ogni uomo aveva un genius personale, che lo accompagnava dalla nascita alla morte, influenzando la vita e le fortune dell’individuo. Per questo era onorato nel giorno del compleanno, il genetliaco appunto. Con il tempo, specialmente in epoca imperiale e in contatto con il pensiero greco, il genius assunse connotazioni più interiori e psicologiche, simile al daimon greco. Esso risiede nella fronte, da cui il gesto di toccarsela quando si ha una buona idea o si ricorda finalmente qualcosa.
Only mad dogs and Englishmen, ovvero il demone meridiano
Entriamo ora nel cuore del collegamento tra un’altra entità simile alle prime due, il dàimon personale platonico, e il demone meridiano della tradizione cristiana ed esoterica. Questo confronto è affascinante perché unisce visioni del mondo molto diverse ma compatibili sul piano dell’espressione simbolica: la filosofia greca classica, la spiritualità cristiana tardo-antica e medievale e l’esoterismo tradizionale.
Il dàimon personale lo troviamo in diversi dialoghi platonici quali il Fedro, il Simposio e la Repubblica, dove viene presentato come una entità mediatrice tra il mondo delle idee e l’anima umana (Simposio); un principio individuale dunque, simile in questo al genius romano, che guida l’anima verso la sua «via propria» (Repubblica, mito di Er), ma anche guida interiore, come descritta da Socrate nell’Apologia.
E dunque il parallelismo sia con il jiin arabo musulmano, sia con il genius romano sono evidenti, dato che anch’esso agisce sia influenzando l’individuo come coscienza o destino personale, suggerendo, orientando, sia determinandolo dall’esterno come tramite tra il mondo della materia e quello delle idee.
Ed arriviamo così alla figura del «demone meridiano», appunto quella che compare nelle ore più calde e che «solo i cani pazzi e gli inglesi», come appunto recitava il titolo del disco di Joe Cocker, osano affrontare. Questa entità, a sua volta diretta filiazione della genealogia daimon, jinn e genius, lo troviamo già nell’Antico Testamento dove si allude a un demone di mezzogiorno: «Né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno» (Salmi 91:5-7).
Evagrio Pontico, nel suo Trattato pratico sulla vita monastica, interpreterà il demonio meridiano come «Il demonio dell’accidia, denominato anche “demonio del mezzogiorno”, è il più gravoso di tutti i demoni: esso s’incolla al monaco verso l’ora quarta e ne assedia l’anima fino all’ora ottava».
Cos’è, dunque, l’accidia o acedia? Akedia nel greco classico indica la mancanza, il venir meno di un interesse, un’attenzione, una sollecitudine: è quindi uno stato di scoraggiamento, di sconforto, un sentimento che rasenta la disperazione perché non si scorge più la possibilità di un senso e, dunque, di “salvezza”: la famosa litografia di Durer la rappresenta magistralmente. Nella bibbia greca dei LXX c’è un’indicazione preziosa per individuare chi si trova nell’acedia. Il profeta anonimo, narrando la propria missione, proclama: «Lo spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione, mi ha mandato a portare la buona notizia ai miseri … per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro … un canto di lode invece dello spirito di acedia» (Isaia 61,1-3).
Nella tradizione cristiana, il primo a parlare dell’acedia è Origene che la indica, non a caso, come tentazione subita da Gesù nel deserto e la individua come assopimento, intontimento, perdita di vigilanza. Poco più tardi Evagrio identificherà l’acedia e la descriverà tra le otto passioni, le otto tentazioni contro le quali il monaco deve lottare: un “demonio” che assale tentando di invadere la persona fino a offuscare lo sguardo del cuore, fino a travolgerla per trascinarla ai bordi della patologia psichica grave, fino alla depressione. Sarà lo stesso Evagrio, riprendendo un’esegesi rabbinica al Salmo 91,6, a definire questa tentazione «demone meridiano» perché è proprio verso mezzogiorno si fa sentire. Gustave Flaubert ne narra all’interno del suo romanzo breve Le tentazione di Sant’Antonio.
Le caratteristiche del «demone del meriggio» sono dunque che colpisce a mezzogiorno, cioè nel momento simbolico di massima luce e calore. Per i Padri del deserto, stiliti, anacoreti, penitenti, eremiti, esso rappresentava la tentazione della noia spirituale, del vuoto, della perdita di senso nella vita religiosa. Cassiano descriva anche i sintomi di chi era preda di questo demone: accidia abbiamo detto (apatia dell’anima), distrazione dagli esercizi spirituali, futilità, scoraggiamento. Il suo attacco è sottile dunque, non si tratta di passioni estreme ed appariscenti come la lussuria o l’ira, ma agisce in profondità quando si è già innanzi nel cammino spirituale, spesso nel momento più avanzato.
Qui è interessante notare come, per altre scuole iniziatiche esoteriche, il mezzogiorno rappresenti invece il massimo momento in cui si riceve la luce dello spirito, e non si deve avere paura di questa esposizione. Evidentemente la realtà concreta dei padri del deserto costituiva una base esperienziale all’evitare invece questi momenti. Ancora oggi, nelle assolate regioni meridionali, quelle subito dopo mezzogiorno sono dette “controre” a significare la loro caratteristica avversa.
Dal punto di vista esoterico ne parla Renè Guénon, quando l’iniziato raggiunge il suo “mezzogiorno” interiore (la piena chiarezza), si apre anche il pericolo di essere deviati da un’ombra che imita la luce. Questo è il “demone meridiano” della contro-iniziazione: essere abbagliati da una falsa luce, la tentazione dell’orgoglio spirituale, dell’autosufficienza, del distacco dal mondo. La crisi del meriggio è dunque un passaggio iniziatico: il rischio di una tentazione che diventa prova di autenticità del cammino.
La controra
Fin dall’antichità, queste ore sono oggetto di attenzione: nel Fedro, Platone si avvia verso mezzogiorno, definito «l’ora […] che si dice immota»: in questo momento avviene un illusorio solstizio: il sole si arresterebbe a metà del suo corso infuocando cielo e terra; le cicale friniscono e inducono così una sorta di torpore mentale, ipnotico, spiazzante. Per evitare queste dislocazioni gli uomini abbandonano i luoghi esposti e si rifugiano al coperto, tranne, ovviamente i mad dogs e gli englishmen.
Forse lo fanno per vedere l’apparizione di Pan, delle Ninfe e delle altre divinità che possono invasare e possedere gli incauti che escono nella controra. Nel dialogo platonico Socrate dice: «in questo luogo sento una presenza divina, così che non ti devi sorprendere se procedendo nel discorso io ne sarò posseduto» e descrive quindi una sorta di stato estatico: «Sento il petto tutto gonfio, non ti sembra […] che io sia tutto preso da un’ispirazione divina?» Non ci ricorda forse l’espressione estatica di Joe Cocker durante la famosa interpretazione di Whit a little help from my friends nel sole meridiano di Woodstock? Erano esattamente alle due del pomeriggio!
Il filosofo greco Porfirio, allievo di Plotino, asserisce che nell’ora della massima calura «non è lecito ai mortali entrare nei templi, perché è la via degli immortali». Anche Giacomo Leopardi nel settimo capitolo del suo Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, del 1815 (Del meriggio), tratta di queste credenze.
In realtà diversi lavori hanno tematizzato l’aura di magia e incantamento che accompagna l’apparizione in questo tempo delle potenze soprannaturali. Paul Bourget in Le démon de midi, del 1914, identifica questo demone nel desiderio sessuale che assalirebbe uomini e donne a metà della loro vita, come accadeva per i monaci nel deserto. Wilhelm Jensen nel romanzo Gradiva, del 1903, descrive il protagonista, l’archeologo Norbert Hanold, che camminando tra le rovine di Pompei sotto il sole di mezzogiorno, ha l’impressione di vedere dal vero la fanciulla raffigurata in un bassorilievo. Sigmund Freud dedicò all’interpretazione di quest’opera il suo saggio Delirio e sogni nella “Gradiva” di Jensen, del 1907. Al romanzo si sono ispirati anche dei film: Gradiva, di Giorgio Albertazzi, del 1970, e Gradiva (C’est Gradiva qui vous appelle) di Alain Robbe-Grillet, del 2006.
Nel film del 1963 I Basilischi di Lina Wertmuller, la voce fuori campo nomina ripetutamente la “controra” a sottolineare la staticità e apatia dei personaggi del paesino lucano in cui si svolge la storia.
Ecco dunque che il Genio della lampada arriva sino a evocare il sogno dei tanti che a Woodstock cercavano, come disse la sirena Grace Slick: «A new dawn», una nuova alba per quella umanità che credeva nel potere della musica, di un demone meridiano benigno, come quello di Aladino, evocato da una folla di ragazzi e ragazze che credeva, e ancora crede, in un altro modo possibile.
Raffaele K. Salinari
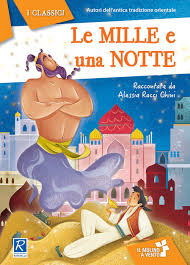
Joe Cocker e la Lampada di Aladino, da Alias 31-5-2025
Pubblicato il 31 Mag 2025 in Articoli, In Evidenza
